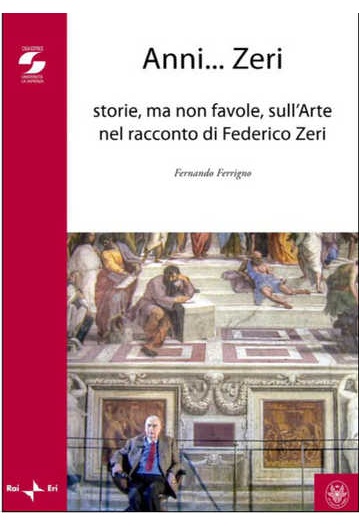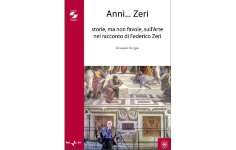- Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore
- Biblioteche Pubbliche Statali
- Diritto d'Autore
- R.P.G. - Registro Pubblico Generale delle Opere Protette
- Comitato Consultivo Permanente per il Diritto D'Autore
- Opere orfane
- Opere fuori commercio
- Violazione dei diritti di proprietà intellettuale
- Unione Europea
- Focus attività
- CREDA
- Norme di riferimento e link utili
- Diritto d'autore - Prestito
- Diritto d'autore - Reprografia
- Contributi
- Biblioteche non statali
- Capitale italiana del libro
- Contributo alle biblioteche per acquisto libri. Sostegno all'editoria libraria
- Editori di arte e turismo
- Fondi indifferibili
- Fondo promozione lettura
- Piccoli editori
- Premi Nazionali per la Traduzione
- Pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale
- Ripartizione del fondo per il diritto di prestito pubblico
- Tax Credit Librerie
- Traduttori editoriali
- Tutela patrimonio bibliografico
- Attività
- Accademie & Biblioteche d’Italia
- Acquisti coattivi
- Albo delle librerie di qualità
- Autorizzazione per Mostre
- Biblioteca Italia
- Deposito Legale
- Dichiarazioni di interesse culturale
- Digitalizzazione
- Libera circolazione
- Patrocini
- Scarto del materiale bibliografico
- Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN)
- Tutela patrimonio bibliografico
- Vigilanza
- Notizie
- Calendario eventi
- Amministrazione trasparente
- Disposizioni generali
- Organizzazione
- Consulenti e collaboratori
- Personale
- Bandi di concorso
- Performance
- Enti controllati
- Attività e procedimenti
- Provvedimenti
- Controlli sulle imprese
- Bandi di gara e contratti
- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
- Bilanci
- Beni immobili e gestione patrimonio
- Controlli e rilievi sull'amministrazione
- Servizi erogati
- Pagamenti dell'amministrazione
- Opere pubbliche
- Informazioni ambientali
- Interventi straordinari e di emergenza
- Altri contenuti - Corruzione
- Altri contenuti - Open Data
- Altri contenuti - Accesso civico
- Altri contenuti – Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati
| Titolo | CondividiSu |
|---|---|
Apertura e mobilità del Medioevo europeo |
All'Accademia delle Scienze di Torino mercoledì 25 gennaio
si terrà la conferenza.
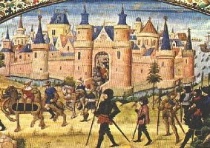
Mercoledì 25 gennaio si terrà la seconda conferenza de I Mercoledì dell'Accademia. Il Prof. Giuseppe Sergi (Università di Torino), tratterà il tema "Apertura e mobilità del Medioevo europeo".
Ore 17.30, ingresso da Via Accademia delle Scienze, 6
La storiografia tradizionale insisteva sulla decadenza
strutturale del sistema viario romano: è il solo aspetto che
risulta confermato nella ricerca medievistica degli ultimi
decenni.
Il fatto che non esistessero più grandi strade lastricate
(viae stratae, appunto), non significa tuttavia che nel medioevo ci
fosse un rallentamento della circolazione degli uomini. Fasci di
strade parallele più strette e per lo più sterrate,
aree di strada corrispondenti a direzioni di flusso non facili da
cartografare, sistemi di capillari più locali erano al
servizio di una mobilità comunque accentuata e
caratterizzata da una forte opzionalità dei percorsi.
La grande fama dei pellegrinaggi medievali ha fatto talora supporre
che esistessero strade specializzate in viaggi penitenziali e
devozionali: non è così. Nelle «aree di
strada» viaggiavano indistintamente pellegrini, mercanti,
armati, conduttori di greggi e monaci-intellettuali.
La strada medievale non è da considerare, dunque, come
elemento stabile del paesaggio che condizionava l'attività
costruttiva: sono in completa crisi le interpretazioni secondo cui
la maggior parte dei castelli nasceva a presidio dei luoghi di
passaggio, o le ricostruzioni che supponevano ‘linee' di
edifici religiosi posti lungo le vie dei pellegrini.
I poteri di maggior livello - regi soprattutto - si impegnavano a
tutelare i passaggi obbligati: è il caso dei valichi alpini
maggiori, quelli più nettamente tagliati nella catena
montuosa.
In questo quadro - meno comodo ma più mosso e variabile
rispetto all'impero romano e agli stati moderni - i contatti fra
regioni lontane d'Europa sono stabilmente intensi. I viaggi
più noti, perché celebrati dai cronisti, sono quelli
dei re alla guida di eserciti o dei maggiori intellettuali che si
spostavano fra biblioteche monastiche, scuole delle cattedrali,
corti principesche.
Ma al di sotto di questa mobilità di vertice c'è un
tessuto costante di comunicazioni e contatti: i protagonisti erano
funzionari pubblici, nobili alla ricerca di punti di radicamento
sempre nuovi, chierici e monaci in movimento fra una
pluralità di enti religiosi, maestri impegnati in diverse
sedi universitarie, podestà che mettevano la loro
professionalità al servizio di vari comuni, mercanti che
mantenevano le connessioni fra mercati settimanali e fiere
annuali.
La stessa economia altomedievale, che gli studi fra Otto e
Novecento ritenevano «chiusa» e fondata sul baratto
(con un'idea sbagliata purtroppo ancora oggi prevalente nella
cultura diffusa) era invece aperta e monetaria.
Per ulteriori informazioni sui prossimi convegni il link al sito dell'Accademia delle Scienze >>>
Fotogallery